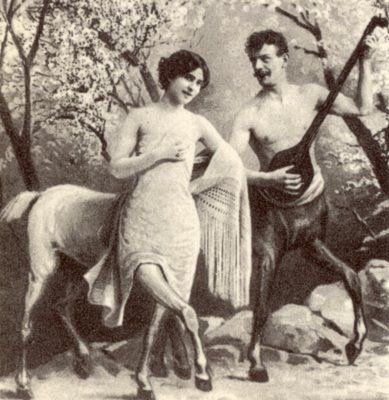VEDI I VIDEO Perché leggere, perché scrivere , “Dialogo di un venditore di almanacchi e un passeggiere” di Ermanno Olmi, dalle “Operette morali” di Giacomo Leopardi, (1954) , “Filastrocca di Capodanno” di Gianni Rodari
Firenze, 31 dicembre 2016 – Cari amici, eccovi anche quest’anno, per ricordare il 2016 trascorso insieme e festeggiare il 2017 in arrivo, un ampio florilegio di quanto avete scritto nel corso dell’anno a commento dei post apparsi giorno dopo giorno in queste Notizie! Un mosaico citazionale che viene liberamente a configurarsi come un suggestivo testo unico a più mani, una sorta di commento dei commenti del nostro blog!
Evviva dunque, e auguri cordialissimi! Che il 2017 sia per tutti voi, come anche l’anno scorso abbiamo augurato, un anno pieno di gioia e serenità! Sempre in viaggio, soli e insieme, fiduciosi pellegrini delle poesia, come l’opera di Pietro Paolo Tarasco che illustra questo post suggerisce!
E ancora auguri, auguri di cuore anche con una propiziatoria e in fin dei conti saggiamente ragionevole filastrocca di Gianni Rodari che dice:
Filastrocca di Capodanno
fammi gli auguri per tutto l’anno:
voglio un gennaio col sole d’aprile,
un luglio fresco, un marzo gentile;
voglio un giorno senza sera,
voglio un mare senza bufera;
voglio un pane sempre fresco,
sul cipresso il fiore del pesco;
che siano amici il gatto e il cane,
che diano latte le fontane.
Se voglio troppo, non darmi niente,
dammi una faccia allegra solamente.
A domani!
Marco Marchi
I COMMENTI PIU’ BELLI DEL 2016
Giacomo Trinci
Iterazioni, chiasmi, anafore, presentano lo straordinario e smagliante spartito di questa musica risucchiante, che fa percepire in modo forte al lettore che si fa ascoltatore quella ‘minorità’ che è una categoria deleuziana, in accezione cromatica, e musicalmente minore. Il lessico dannunziano, con annessa l’internazionale simbolica, si disintegra e sfarina nell’iterazione sonnambolica, nelle anafore da ipnosi acustica. La poesia di Campana risucchia se stessa in un’autocombustione assoluta che lascia il corpo del poeta da solo, zoppicante e nomadico zingaro della vita. La voce che canta in questa grande evocazione di materia che spossessa, è quella di misteriose cantilene che ci raggiungono dal profondo di noi stessi, che ci sfanno.Non ci appartengono ed emergono in ironici bamboleggiamenti, in quieta follia. Grande musica di uno spossesamento corporeo e mentale.
Tra Leopardi e Gramsci: lo strappo gracile del corpo, straziato tra pessimismo della ragione e ottimismo della volontà, o meglio di una vita che, ostinatamente e ciecamente “risorge” da se stessa, dalla propria mortalità apparente. La forma “ragionante” data alla poesia in questa fase della poetica pasoliniana apre fratture, ospita ferite che si faranno col tempo vieppiù spalancate, aperte, fino a sgombrare il campo dalla Poesia “poetica” degli esordi friulani, e dalla poesia in generale “poetata”. Un genio del “disabitare”, una forma dell’eresia che guarisce, attualmente, dalla velenosa, tossica sete del conformismo.
All’origine della poesia, così mi piace pensare, della grande poesia, c’è sempre questo movimento impossibile e necessario, fatto di sventata, coraggiosa verità: un movimento dove, appunto, “si vive altrove”, per dirla con Pascoli. In questa straordinaria raccolta di Giorgio Caproni, il movimento rapinoso dell’invenzione lirica è miracolosamente inciso in una materia musicale di inimitabile fattura: la durezza e la fluidità insieme, la tagliente evidenza delle figure eppure la loro chiarezza, vestono l’enigma della madre fanciulla in modo perfetto. Il combinato di semplicità e complessità figurale risulta calato nella speditezza quasi metastasiana delle magre strofe, dove il settenario, l’ottonario e il novenario sembrano sgranare l’uno nell’altro in questo rosario piano e mormorato. La verità è nella voce del poeta stesso: rugosa e dolce, chiara e opaca, reticente e impavida: come ogni vero canto del perduto.
Daniela Del Monaco
L’estate è fuggita via in un attimo, portandosi dietro tutte le aspettative, le attese, le speranze di ciò che poteva essere e che è rimasto inesorabilmente incompiuto. La poesia di Tarkovskij è pervasa da questo sentimento di nostalgia, tipico della condizione umana di non appagamento dovuto alla nostra esistenza finita, limitata che rende la vita una corsa estenuante verso una soddisfazione irraggiungibile.
In “Veglia” di Ungaretti il senso della morte deriva dalla morte dell’altro, rappresentato espressionisticamente con una forza quasi caricaturale. Non vi è stasi, né pace in quella morte, anzi, è come se il movimento fosse stato bloccato per sempre nell’immagine drammatica della bocca digrignata rivolta alla luna, simbolo della bellezza della vita. E’ con le mani congestionate del compagno ucciso, mani che hanno penetrato il silenzio che lo circonda, che Ungaretti sembra scrivere la sua poesia di denuncia della morte e al tempo stesso di resistenza alla sua opera di distruzione. Gli ultimi versi testimoniano il suo profondo attaccamento alla vita, un attaccamento non egoistico ma sentito come atto di protesta e di riscatto contro le atrocità della guerra e come proclamazione del diritto degli uomini, di tutti gli uomini, di vivere.
framo
Al di là dell’occasione da cui ha preso corpo e al di là del momento in cui ha preso forma, ogni poesia della Dickinson sgorga dall’esercizio volontario e lucido del silenzio e ha come cassa di risonanza lo sguardo interiore del lettore di ogni luogo e tempo. La sua ricerca sensibile, raffinata e acuta, oggettiva e sensuale al contempo, si dilata ben oltre i confini di una mente “privata” e l’eco della sua voce oltrepassa a dismisura le pareti della stanza di un corpo tutt’altro che congelato. Questo testo duro, scabro (e come potrebbe essere altrimenti, dato il tema?) “registra” in modo mirabile i postumi dell’esperienza di un dolore estremo ed è proprio lì che ci spinge, ci fa addentrare, dandoci la chiave per conoscere e per riconoscere, ci fa crescere ed arricchire. Nello spazio composto e separato della moltitudine dei suoi versi, sempre illuminanti, ogni volta entriamo per uscirne con uno sguardo altro, più consapevole, aperto, vibrante, come rigenerato. E’ l’effetto dell’incontro con l’espressione di una poetessa senza tempo e senza età, del tutto estranea alla condizione di un “sepolto vivo”. Meravigliosa.
“… Noi siamo i poeti – e rimaniamo con i paria / ma, straripando dalla riva / noi contestiamo Dio alle Dee / e le Vergini agli Dei”. Vita e versi da vero poeta: un paria senza più patria dove desiderare ancora di potersi accomodare, come chiunque farebbe a casa propria. Depauperato del luogo di origine – di cui scotta il tradimento e verso il quale non può che provare un senso di radicale estraneità, al punto estremo di volersi disfare di ogni segno di riconoscimento che appartenga alla precedente identità -, rischia di prendere le distanze anche dalla lingua stessa che lo nutre. Con tutto il disprezzo per la pesantezza del quotidiano, del volgare e del banale, isolato, incompreso, senza più radici (verso cui, in segreto, permane un forte senso di disperato attaccamento), oppresso e alla deriva, si affida all’arte come unica patria di elezione esplorabile, lungo il cui sentiero, forse, spera ancora nella possibilità di rinvenire un segno puro e concreto della presenza di un orizzonte meno ostile e più familiare. Con Rilke, la più grande!
“Scende la sera, i campi diventano azzurri, la terra orfana. Chi mi aiuta ad attingere l’acqua dal pozzo profondo? Non ho nulla, ho perduto tutto lungo il cammino. Dico addio al giorno, incontro la stella. Dammi da bere” (da “La culla”). Parole di un passante sensibile e irrequieto, come noi, quelle di Arsenij Tarovskij. Eppure chi le pronuncia non è un viandante qualsiasi. Alla finitezza umana e del mondo, al flusso inesorabile della storia e agli scacchi del destino, lui, eppure, è riuscito a sottrarre e a trattenere stati intensi di esperienza sensoriale, sprazzi di benessere e quiete, bagliori di gratitudine e di matura accettazione, spazi simbolici di rara bellezza (la foglia che, posandosi, si trasfigura in farfalla, o in altra mano, o in stella …). Pause terrestri di rarefatta sospensione … oasi troppo esigue di incorrotta natura (“non sono bruciate le foglie, non si sono spezzati i rami”). Troppo poco e troppo effimero, però, per placare la sete di un viaggiatore inquieto e solitario che necessita di una sempre più inattingibile sorgente d’acqua profonda.
tristan51
La poesia, la musica, l’arte, ma anche la natura…. Con i loro imprevisti miracoli, con le loro soggioganti seduzioni e i loro risarcimenti. Ma purtroppo, come giustamente dice Madame Merle a Isabel Archer nel “Ritratto di signora” di Henri James, “ci sono momenti in cui nemmeno Schubert può dirci qualcosa”. Arsenij Tarkovskij registra da par suo, in poesia, queste evenienze nefaste, queste deficienze e queste dolorose amputazioni della balenata pienezza, queste rotture dell’idillio.
Straordinaria, come sempre, la lettura di Ungaretti, e straordinaria, ancora nel video, l’introduzione affettuosa ad Annina! Straordinaria anche la risposta al quesito di Pasolini intervistatore per “Comizi d’amore”.
Federigo Tozzi è un autore “difficile”, senz’altro al di sotto del suo valore presso il grande pubblico, soprattutto perché è un grande pessimista, novecentescamente debitore della lezione di Leopardi. Scrittore senza consolazioni, Tozzi invita, come Svevo e come Pirandello, all’attraversamento e all’interrogazione del “non senso” della nostra esistenza. Tuttavia, a differenza dei suoi congrui e straordinari compagni di strada, Tozzi rifiuta qualsiasi instaurabile complicità fra autore e lettore. Amaro come Svevo e ineccepibile come Pirandello, Tozzi non ci fa mai sentire “intelligenti”, ma si limita a mostrarci come in realtà stanno (come in realtà inesplicabilmente, tragicamente stanno) le cose della vita. E questo piace poco.
Matteo Mazzone
Il pullulare di linguaggi è la fenomenologia denotativa della parola poetica zanzottiana: essa attraversa tutti i territori del negativo, descrivendo la disperazione psicologica di un io assediato da nevrosi di memoria gaddiana e, dunque, da frantumazioni relazionali e sociali. Ma tale magma concentrato ed apparentemente impenetrabile di negatività non si esaurisce col suo ripresentarsi rigido ed immodificato: Zanzotto tenta la strada della parola “calda”, che come una sonda, resusciti un qualcosa di autentico e ricco di valore, e che sia barlume, alba di una rigenerazione vitale con quella materia così negativamente connotata nel suo esprimersi. In sostanza, una nuova possibilità di comunicazione con il mondo. Divverrà poi il dialetto o “parlar vecio” l’idioma che segnala, allo stesso tempo, un rapporto amoroso e tragico colla realtà e colla vita.
Una meraviglia che mi commuove sempre: il Gaddone più dolce si condensa tutto in questa lirica, che rivela quella sua anima fulgido-algida così desiderosa di comprensione e d’amore. E l’autunno non può che essere, fra le stagioni, quella che più si fa specchio introiettante in Carlo Emilio, ora non più solo il nevrotico Gadda: due facce della stessa medaglia, o meglio, della stessa persona. Si smussa, per un atomo-attimo, il suo continuo ribollimento nevrotico-nevrastenico di nevrastenie da gigante buono apparentemente misantropo. Alì Oco de Madrigal si personalizza, si liricizza e, psicoanaliticamente parlando, si sublimizza.
Un poeta che non stanca mai il suo lettore: Marchi ricorda già la funzione ironica e demistificatoria della letteratura per Aldo. Si esce dalla epopea del D’Annunzio, impegnato corpo e sangue nell’eroicità della sua poesia per istradarla su di un nuovo motivo, ora post-decadente, ora avanguardistico, ora personale stilema di ricerca poetica. Con Aldo nasce la nuova letteratura – già anticipata dalla semplicità pascoliana -: essa é un grido tenue, timido, sarcasticamente denunciatorio, specchio della condizione dell’uomo moderno. Un leitmotiv instancabilmente variegato, giustamente osceno, antiborghese, come quella “violacciocca che fa certi lavoretti con la bocca”. Per Aldo l’io lirico diviene proiezione di un io assente, impossibilitato, irrealizzato e irrealizzabile: solo un :riflesso, fugace, repentino, istantaneo. Questo é la nuova letterutura propugnata: semplicità, comicità, riso, commozione. Aldino, mi cali un filino?
Marco Capecchi
La madre propria e le madri degli altri: questa è la cifra, probabilmente della poetica e dell’esistenza di Pasolini. Fare i conti con l’onnipresenza e l’onnipotenza della Madre, fosse quella biologica o la Madre Terra. E’ in questo universo che si compie l’amara e sofferta vicenda della vita.
La ginestra di Leopardi, il glicine di Pasolini, la speranza disperata e l’esistenza stroncata, il rinascere della natura e gli abissi del vivere. Due poeti immensi che differentemente riflettono sul rapporto tra vita e senso dell’esserci.
La modestia dell’uomo che si trasfigura in Betocchi nel Grande Poeta.
Elisabetta Biondi Della Sdriscia
Questo madrigale di Torquato Tasso è di una bellezza e delicatezza che lasciano senza parole! Il poeta attraverso settenari ed endecasillabi liberamente alternati, a rima baciata, crea un notturno dall’atmosfera incantata, un silenzio sacrale al quale concorrono tutti gli elementi della natura, quasi per reverente omaggio alla luna che con il suo candore rischiara le tenebre notturne, dissipandone le ombre. In questa notturna quiete sono desti solo il poeta e la sua amata, ma anche i loro baci e i loro sospiri sono silenziosi, non devono turbare il silenzio candido, virginale della quiete notturna. Nell’antitesi tra oscurità della notte e candore luminoso della luna è forse suggerita l’opposizione tra passione sensuale e algida purezza, la luna nell’antichità rappresentava infatti Diana cacciatrice. Se Tasso conosceva lo splendido notturno di Alcmane, non vi sono infatti certezze a tal riguardo, l’inserimento finale degli amanti introduce a sorpresa, un elemento di delicata sensualità che se da un lato interrompe l’immobilità della notte, non ne turba però il silenzio sacrale: anche l’amore dunque partecipa della sacralità del rito.
Chi conosce la lingua russa ci dice del ritmo trocaico e martellante di questa poesia e la contrappone al ritmo giambico dolce e melodioso di altre poesie più elegiache: io nulla so di tutto questo, eppure amo moltissimo, da profana, la poesia di Osip Mandel’štam, catturata dalla magica purezza dei suoi versi. “Perché l’anima è così melodiosa? canta e ci incanta, rendendo struggenti e concreti gli enigmi esistenziali che ci affliggono… La vita è quella che ci appare riflessa nella sua deformità nell’acqua gelida di una botte, in cui si può sciogliere l’immagine illusoria di una stella come se fosse di sale. Una poesia amara, priva di illusioni, lucidamente profetica, scritta nel 1921, dopo la fucilazione dell’amico Gumilev… Molte delle meravigliose creazioni poetiche di Osip sono arrivate a noi solo grazie alla determinazione e all’amore della moglie Nadežda che le imparò a memoria per salvarle dalla furia iconoclasta del regime. Grazie, Nadežda, l’umanità ti sarà perennemente grata.
Una poesia bellissima, questa di Saffo, che con delicatezza descrive gli effetti fisici dell’amore, quando gli occhi sono colmi di meraviglia e la persona amata ci appare davvero un essere soprannaturale! In un altro carme, di cui ci resta purtroppo solo un frammento, Saffo scrive: “Alzate l’architrave, carpentieri, lo sposo, simile a un dio, è arrivato” (cito a memoria), facendo ancora una volta allusione alla potenza dell’amore che ci fa apparire la persona amata bella come una divinità. Nel frammento vi era forse anche un’allusione alle doti amatorie degne di un dio dello sposo, ma questo nulla toglie alla bellezza dell’immagine e alla capacità che Saffo ha di descrivere le emozioni legate all’amore. Un’ultima considerazione: questa poesia, scritta circa seicento anni prima dell’era cristiana fu scritta da una donna!
Yumiko Nakajima
E’ bellissima la citta’ di Siena, dove ci sono piena dello spirito di Tozzi. Leggendo le scene di Siena nelle opere di Tozzi mi sento come se io stessi passeggiando a Siena; la Torre, la Piazza del Campo, i viali serpeggianti dai quali si vedono della casa uno all’altra e all’improvviso e’ aperta la vista e si vedono il panorama della citta’, la discesa e la salita e il suono della campana, ecc. Nelle opere di Tozzi, oltre alla descrizione della citta’ di Siena, sempre presente la figura del padre, che ha il potere e piena della capacita’ anche di togliere la luce dal figlio, che rimane sempre nel buio. Ma, nel podere, e’ molto misterioso, all’inizio del racconto, anche il grande diventa il figlio morente che ci allude il Cristo crocifisso prima che la luce (il padre) si e’ spenta improvvisamente.
Silvia Tozzi
In anni passati, il nome di Tozzi ha avuto momenti di attenzione nelle rassegne culturali, mentre oggi si leggono le sue pagine più per scelta personale, che per suggerimenti dall’alto. Non c’è in Italia un clima favorevole alla sua ricezione. Ma stranamente, per esempio in Russia, c’è chi ha cominciato a giudicare qualche suo libro come “capolavoro di modernismo europeo” (Michail Viesel nel supplemento de La Repubblica “Russia Beyond the Headlines”, 17 settembre 2015). Alla traduttrice Ekaterina Stepantsova si deve l’uscita, per la prima volta in Russia, di alcune novelle e di Con gli Occhi Chiusi, e la sua collega Oksana Mushtanova ha tradotto Tre Croci. Magari, chi ha l’orecchio educato a Dostoevskij può essere più sensibile all’ascolto di Tozzi?
m
Per celebrare “Uncle Walt” bisogna lasciare la parola ad un altro grande, Harold Bloom: “Whitman’s full aesthetic achievement is still undervalued and misunderstood. He is the greatest artist his nation has brought forth. Indeed, no comparable figure in the arts has emerged in the last 400 years in the Americas”.
La potenza dell’immaginario montaliano dà le vertigini: ci sorprende e, oscuramente, ci stordisce. Qui sembra assistere a uno scavo in un mondo plumbeo e persefonico, dolorosamente intarsiato di memorie (o addirittura niente più che ipotesi) di vita e di pienezza. Così eleusino ma anche segretamente dionisiaco, Montale tuttavia riesce miracolosamente a sfuggire a qualsiasi empito retorico.
Dirò una cosa che per alcuni è, ancora oggi, una bestemmia: Pasolini è uno dei massimi poeti (e sottolineo poeti) del Novecento.
Aretusa Obliviosa
La prima parte di questa poesia di Montale sembra una rivisitazione in chiave novecentesca della “Quiete dopo la tempesta”. E davvero Leopardi non è mai sembrato tanto ottimista. La lezione del recanatese la sento viva fin dalla scelta lessicale e dalla sfera semantica della vaghezza. Mi riferisco ai “rari uomini, quasi immoti”, a “invisibile”, dove però il vago si va progressivamente connotando come assenza di vita. Si veda la nebulosa “fuliggine” anticipatrice di una “primavera inerte, senza memoria”. La strada verso un’inquietudine tutta novecentesca e storicamente connotata (se si pensa al ventennio che si concluderà con la guerra) è ormai sbaragliata. E significativo è il fatto che la “vita” trovi le sue coordinate nell’antico, unica dimensione del possibile, in quella “dolce ansietà d’Oriente” dove le parole di Dora, o forse la parola stessa ritrova un senso nella non ancora perduta facoltà di iridare, propria di una “triglia moribonda” ma pur sempre viva. Con essa, nella sua lotta, nella sua irrequietudine, la protagonista sembra quasi identificarsi. Si procede dunque quasi per associazioni. E trovo perfettamente calzante la similitudine del volo accidentato degli uccelli di passo nelle “sere tempestose” che torna – a me almeno così pare – a coniugarsi con il lessico leopardiano. Ma l’hinc et nunc non è la quiete, condizione a posteriori rispetto alla tempesta, ma una vera e propria cinetica della dolcezza, che per poter esistere (o resistere?) deve turbinare, in una disperata guerra contro l’inerzia della morte. Forse proprio nell’incessante vorticoso turbinio di questa guerra, nel non arrestarsi un attimo sta la risposta cercata dal poeta. Forse il lago di indifferenza è uno strato gelato solo in superficie, ma quanto mai agitato in profondità. Forse. Ma è un’energia quella che fa resistere Dora che solo in un topo bianco d’avorio, amuleto della salvezza, trova ragion d’essere. Essere ed esistere, appunto; secondo ritrovati connubi novecenteschi, connotabili come ormai collaudati vade mecum di resistenza da contrapporre a contingenze di precarietà, a tempi di incertezze difficilmente decifrabili. Nella seconda parte il lessico si fa più dannunziano (“mirti”, “tigli”, “irti”), in una mediterranea Carinzia dove l’esistenza ritrova i ritmi distesi di una più svagata quotidianità. Condizione questa tuttavia ritrovabile per accensioni ed avvampi, e non persistente. La sera sopraggiunge infatti impietosa e accompagnata da quasi lugubri gemiti che evocano un passato in cui ci si riflette come in uno specchio annerito. E lo specchio rimanda “errori imperturbati”, in cui viene quindi meno il salvifico turbinio che nella prima parte si preannunciava. Di rassicurante sembra rimanere solo una leggenda, impressa nelle tessere di un mosaico profumate d’Oriente e appartenente però alla dimensione di un passato remoto e di una geografia della distanza che vede la sua stella polare in una Ravenna ormai lontana. Unico appiglio per una salvezza da ancorare allora al solo presente è il tradizionalmente nobile alloro, ridotto alla confortante misura domestica di pianticella aromatica da tenere in cucina, ennesimo benefico amuleto nonché antidoto contro un passato prossimo che continua a distillare veleno, contro l’ombra prepotente di una fede feroce alla quale per resistere non si può tornare a pensare.
Giacomo Trinci
La genealogia dell’a-morale: in questo mirabile poemetto-ballata la tenaglia etico-politica che caratterizza tutta la stagione creativa che fa seguito alla giovinezza friulana si condensa in modo altamente eloquente. Queste Madri lucidamente disegnate nella loro ansia servile sono i progenitori della nostra ignavia post-politica e dopostorica. Tutto questo è reso,immergendo nella bruttura “civile” la bella veste di una Poesia ancora eloquente, leopardianamente tesa; seppure come corda che cominciava ad essere lisa: la corda pazza ed alta della poesia, appunto. Presto, la “ballata”stingerà del tutto nel pragma di un mondo che non vuole più la poesia, non saprà che farsene e la userà solo come inutile ninnolo per aggiornare le proprie miserie piccolo borghesi: da salò a salottino.
Duccio Mugnai
Il racconto e la poesia di Arturo Loria sono davvero molto belli. Anch’io dovrei studiarlo di più. E’ una mancanza… La scelta del mondo animale come repertorio simbolico della vita, le sue contraddizioni e la lotta necessaria, spesso tragica, per battersi amaramente, ma in modo fiero contro le avversità, non è casuale; anzi trova davvero moltissimo materiale esistenziale per descrivere e riflettere le passioni umane, le quali spesso sono oggetto di interpretazione puramente intellettiva, mentre è l’istinto che dovrebbe essere preso come chiave di lettura. “Il rostro” rapace e tagliente di un uomo aperto alle culture, alle letterature e filosofie del mondo, seppur ferito dalla violenza sociale e pubblica, viene sublimato da immagini di prigionia e morte. Si rivendica non solo il diritto alle proprie scelte e alla libertà, ma anche l’essenza stessa della propria natura, feroce per sopravvivenza, mai quanto la fredda e disumanizzata vivisezione delle anime più coraggiose, di cui una società ipocrita e, allo stesso tempo, un regime dissimulato non aspettano altro che il cadavere d’autopsia per mostrarlo come trofeo.
Lo sfinimento della vita per un uomo di fede, lo sfibrarsi ai colpi della vecchiaia, delle delusioni, delle amarezze, giorno dopo giorno. La fiammella di una candela alla Vergine, a cui ci si affida, apparentemente nell’umiltà della speranza, in realtà bramando ancora la pluralità infinita di illuminazioni esistenziali. Dietro tutto questo la scoperta dolorosa, ma inequivocabile e coraggiosa: “[…] di quisquilia in quisquilia / sono un uomo che muore”. E’ un grandissimo poeta, ancor più un uomo umile e di vera, semplice fede, forte in metafora quanto la durezza di un sasso. Difficile trovarne nell’arroganza quotidiana del mondo.
Nel leggere in lingua originale il componimento di Keats, la musica ed il suono finiscono per soverchiarmi totalmente, per superare ogni possibilità di concettualizzazione. E’ canto in continuità, quasi specchio sonoro, volutamente e forzatamente cercato nella sua naturale creatività, della musicalità dell’usignolo. In inglese ha fascino la ripetitività di strofe, formata ciascuna da una quartina a rime alternate e due terzine a rime simmetriche. Una sonorità che affanna e toglie il respiro. Come una malattia alla vita.
Maria Antonietta Rauti
Costance Dowling: questo il nome dell’attrice americana da cui il Poeta ha subito una delusione amorosa a cui pare legato il testo poetico che sembra rievocare l’amore inteso in maniera petrarchesca e leopardiana. Gli occhi, la parola, il silenzio, la speranza, la vita e poi il nulla, la morte quale compagna di vita sono incontri importanti tra lo scandire dei versi di Pavese… E poi come non soffermarsi sulla magia dello specchio che si ripete come immagine simmetrica, ma non statica, capace di deformare l’azione facendo”riemergere un viso morto” e capace di far parlare un “labbro chiuso”.
Che musicalità straordinaria tra gli scritti proposti oggi… Che accordi, che note espressive e catturanti tra le voci della letteratura contemporanea!!! Così la poesia dell’amato Matteo Mazzone si sposa, sapientemente, con le “bellezze” di un passato vissuto nel presente… Che dire degli “occhi infiniti” di Giovanni Asmundo? Scoperta, per me, straordinaria, che osserva, scopre e scrive i particolari più nascosti illuminando l’oscurità per far emergere sentimenti antichi… E infine la fluidità spirituale che assume le sembianze di una preghiera nella prosa precisa che riesce persino a “trattenere un lembo di quel colore del vespro” o di far emergere un pudico solletichio tra le dita del Bambinello, nella prosa di Letizia Barozzi, risulta “poeticamente”straordinaria! Complimenti vivissimi da un’amante della letteratura di ogni tempo e lingua.
Una descrizione in versi “deliziosa”, quella di Daria Menicanti, che ha le movenze “deliziose” del soggetto che sfoggia le sue movenze, con una amorevole costante che diletta l’anima e accompagna mente e cuore del lettore… Mensieur et Madame Centaure 1908…
5555
Non conoscevo queste “Postille”… Mi hanno dato conferma dell’onscindibile, inevitabile connubio in Palazzeschi di comico, immoralismo e rsiultato espressivo. Laddove l’immoralismo di Palazzeschi trionfa, l’arte si afferma.
“C’è in queste poesie qualcosa che sembra aggredire il lettore, un fuoco di inquietudine che lacera ogni composta dignità acquisita dal linguaggio poetico e mette in mostra asperità, spigoli, sgradevolezze. Una violenza verbale, un tono musicale che si torce si se stesso con strappi di un’evidenza feroce” (Mario Luzi). I “Frammenti lirici” come “un vortice di accensioni che conferiscono una violenza espressiva, e spesso deformante, espressionsitica, al linguaggio”, l’espresionismo di Rebora come corrispettivo stilistico della “dissipazione del mondo”.
Fin dagli esordi l’anomalia dell’itinerario biografico di Ungaretti, figlio di “spatriati” lucchesi ad Alessandria d’Egitto, persino in senso linguistico elementare è attiva: all’insegna della extraterritorialità, della divisione, della molteplicità che si risolve in forme di smarrimento e di disagio, in mancanza di appartenenze condivise e punti di riferimento certi. Ungaretti vive la sua infanzia e la sua giovinezza in un ambiente trilingue, fra le sollecitazioni provenienti dalla famiglia italiana, dal mondo arabo e dalla cultura francese: uno spaesamento, una miscela di suggestioni disorientanti di premessa al grande, traumatico smarrimento della guerra combattuta sul Carso. All’immagine del deserto si sommano però, precocemente, elementi fondamentali mediante i quali l’input originario si rafforza e trova conforto. Fin dagli infelicissimi anni trascorsi al Collegio Don Bosco e poi alla rinomata Ecole Suisse Jacot si rivela efficiente un bagaglio culturale in crescita, tra rispecchiamento e superamento, che annovera tra i suoi esempi rintracciabili Leopardi e Baudelaire, Nietzsche e Mallarmé.
Cesare
Mi pare quasi vadano d’accordo: il viso corrucciato e tirato della poetessa e i suoi versi, come fiori assetati per vivere cui manca l’acqua da bere. Questa cruda negatività, quasi la Rosselli avesse il mondo a dispetto. Ci si sente pesanti nel leggere questa poesia, pur rispettandola come tutte, non conoscendone almeno io, la motivazione esatta. “Il mondo è un dente strappato” …., “la pioggia è sterile” …, “il mostro” …, “le piccole vipere” …, la speranza vista come danno … , la mano di “marmo” … , ecc. Amelia, nome dolce se vogliamo, dove manca l’incisivo di una “r”, ma poesia che appesantisce l’animo, pure nella sua conclusione di “elefanti”, visti come “ottusi”!
Dante è somma poesia, ma è anche alta catarsi, in un mondo odierno per noi inquinato nei sentimenti d’animo troppo spesso offesi, calpestati, umiliati. Dante descrive, nel bene e nel male, i comportamenti umani, che in sostanza sono sempre gli stessi: cambiano gli scenari, ma l’uomo è sempre il medesimo. Il bello di Dante è per me oggi saperlo riscoprire, lontano dai banchi di scuola, quando la sua lettura era per noi, allora ragazzi, alquanto astrusa e pareva pure tanto distante. Dante è sempre attualissimo, perché descrive nel suo “Inferno” i peccati umani, infliggendo ad essi sanzioni e pene che sarebbero anche ora, se esattamente attuate, esemplari. Questo il mio pensiero in generale sul Divino Poeta, a prescindere dalla poesia oggi trattata e così ben presentata dal Prof. Marchi, avvalorata dalle parole di Mario Luzi.
Isola Difederigo
All’ombra del desiderio più acuminato si fa il dolore, più limpida e atroce la visione di un perduto mondo di luce. “Mare al mattino” è l’unico en plain air della poesia di Kavafis, quello che resta del giorno. L’eros e la memoria, storica e privata, l’idea del tempo che tutto altera, una lingua greca restituita alla sua originaria, inimitabile capacità di astrazione e di sintesi: l’opera di Kavafis si presenta “come una quintessenza della poesia”, celebrando il primato della poesia e dell’arte.
Ha abitato il mondo diviso tra «passione e ideologia», tra le ragioni del corpo e quelle della storia, ha conosciuto lo scandalo della morte affidando a un non-sapere testamentario il voto della sua innocenza, della sua aurorale castità annunciata ad un Pasolini diciannovenne dall’insorgente «gusto della vita e del realismo». Fiorirà e sfiorirà per lui la poesia in forma di rosa, l’esperienza esaltante e dolorosa di creazione e caduta del linguaggio; ma intanto è aprile, mese topico per Pasolini, e a rinascere è il glicine con la sua perenne promessa di resurrezione, con il suo profumo inebriante e sensuale, figura della poesia.
È il Caproni indimenticabile di questa laica e umanissima preghiera, questo modo struggente ed esclusivo di affidarsi alla parola della poesia, l’anima, come a un’improbabile liturgia resurrezionale di figlio-fidanzato, di figlio in croce. Un poeta altissimo, se ancora ad assisterlo è lei, Beatrice-Annina, la grazia che mette ali al suo soffrire.
Giulia Bagnoli
“La Chimera”: capolavoro assoluto del visionario poeta; una personificazione della Poesia, misteriosa e affascinante come una donna, spaventosa come un mostro. La Poesia a cui il poeta aspira è tanto preziosa quanto inafferabile e lontana, ed egli non può che reclinare la testa in atteggiamento servile e continuare disperatamente ad evocarla. Campana cercando la Poesia ne ha scritta una perfetta.
Il dolore personale diventa dolore universale, poiché un’ “ignuda” tomba è il destino comune di tutti i viventi. Di fronte a questa realtà qualsiasi speranza o illusione viene meno (“All’apparir del vero / Tu, misera, cadesti”) e l’uomo non può fare altro che rassegnarsi. Rimarrà attonito, come sappiamo, nello scoprire che il suo destino non è diverso da quello di tutti gli altri. Saranno le ultime tragiche parole di Leopardi.
Bellissima! “Sarà come smettere un vizio”: il “vizio assurdo” di Pavese è sia la vocazione al suicidio che vivere, tuttavia il “vizio assurdo” è anche quel mestiere dello scrittore che coincide con quello di vivere. Il gesto di scrivere diventa privo di senso, soltanto un gesto appunto, equiparabile a quello di togliersi la vita, nella consapevolezza che anche scrivere non serve a niente, se non a difendersi dalle offese della vita (“la letteratura è l’unica arma contro le offese della vita”, scriveva). Ho sempre immaginato Pavese come un uomo “senza pelle” che sente tutto e ad un certo punto non può più difendersi.
Damiano Malabaila
Shakespeare non è solo il Dante della letteratura inglese, davvero uno dei massimi poeti di tutti i tempi… Sempre memorabile, sorprendente, generoso, inesauribile. Un altro grande, Pasolini, lo aveva capito.
Greta Fantechi
La limitatezza umana di fronte al mistero metafisico. Nei suoi versi, Rilke pone dei quesiti che Immanuel Kant definiva inalienabili, delineando così una situazione in cui lʼindividuo, inerme, non può far altro che percepire la propria piccolezza attorniato dalla vastità dellʼuniverso.
Massimiliano Bertelli
Un ritratto magnifico di un poeta che non smetterà mai di stupirci per la modernità del suo pensiero e l’attraversamento consapevole della tradizione. Nel lessico de “I limoni” di Montale, che è una sorta di manifesto poetico, trova spazio anche l’anguilla. Simbolo evocativo della vita e della poesia, molti anni più tardi conquisterà il ruolo di protagonista ne “La bufera”, alla ricerca di “paradisi di fecondazione”. Romano Luperini ci ricorda che, in questo componimento, “la resistenza, la tenacia, gli attributi dell’eticità montaliana pertengono ora al biologico, all’istinto vitale, al freudiano principio di piacere”. Volontà di ricercare un altrove da abitare, lo slancio che ritroviamo dentro noi stessi e che Montale ha mostrato nei suoi versi.
framo
La parola “nazione” presente fin dal titolo in questa poesia di Pier Paolo Pasolini si radica in “nascita”, rinascita per estensione. L’aggettivo possessivo “mia” afferisce sia all’area affettiva (rimanda a pathos, intimità e rispetto) sia a quella desiderativa e prescrittiva (l’ideale cui tendere). Non cellula, organo isolato, singolo tessuto, coacervo o indistinto ammasso: tornare ad essere, farsi “corpo” dotato ancora di nervi e riflessi pronti all’interiore risveglio, da tradurre in gesto, in primis, quindi in prolungata, tenace azione che, divenuta opera, fecondi un possibile, umano e civile, rinnovamento. Pasolini non si smentisce mai.
Una densità di parola, quella di Cristina Campo, che, pur oltrepassando la misura del quotidiano, ne condensa ferocia e durezza. Qui la poesia non è “invito a chiamare (la nostra interiorità) a raccogliere i soffi segreti dell’essere”. Fatta salva, temporaneamente, la purezza della bocca orante, la tragedia del destino umano resta comunque scoperta e inesorabile. Da altri suoi significativi passi apprendiamo allora che altro “non resta che protendere la mano tutta quanta la notte, e divezzare l’attesa dalla sua consolazione, seno antico che non ha più latte // Vivere (…) quelle vie (…) col mendicante livido, acquattato tra gli orli di una ferita”, nella consapevolezza che “fra pietra e pietra corre – sempre – un filo di sangue (…) dove giunge il piede”. Meravigliosa Campo.
Il punto di vista di chi si consuma “all’ombra di una scatola vuota” come unica possibilità in Federigo Tozzi poeta di mettere a tacere l’ambivalenza dei propri moti interiori (eccesso di rabbia repressa e riemersa nel ricordo, insensibilità indotta da anni di paterna indifferenza, autenticità di slancio, condensata in quel “vorrei che mi riconoscesse”, pronunciato una volta salito in ginocchio sul letto, con atto più o meno inconsapevolmente implorante e penitente). E’ il punto di vista che il figlio sembra costringersi ad assumere nel tentativo di conservare un equilibrio almeno apparente, perché sul “suo viso, quasi sempre rassegnato, (…) ora doventato febbrile”, non si imprimano i tratti della follia (il dolore sincero, come è già avvenuto alla matrigna, fa perdere la testa) o quelli dell’ipocrisia che gli preme dentro, e che vede e sente attorno, prima e dopo l’ennesimo, estremo rifiuto, con il rischio di perdere la limpidezza di uno sguardo – “quasi sbiadito”- “che non somigliava a nessun altro”. Testo durissimo e ostico da cogliere nel profondo dei suoi molteplici, non immediati risvolti.
tristan51
Proprio nel 1925, l’anno di pubblicazione degli “Ossi di seppia”, sul periodico torinese “Il Baretti”, Montale dichiarava, rivendicando al proprio operato consapevolezze: “Lo stile, il famoso stile totale che non ci hanno dato i poeti dell’ultima illustre triade, malati di furori giacobini, superomismo, messianesimo e altre bacature, ci potrà forse venire da disincantati savi e avveduti, coscienti dei limiti e amanti in umiltà dell’arte loro più che per rifar la gente”. Il suo è e sarà l’atto poetico che deliberatamente si connota in senso antitetico rispetto alla poesia di Carducci, Pascoli e D’Annunzio: la poesia scabra ed essenziale di un uomo che non può andarsene sicuro, una pronuncia probabilistica e al negativo, sovrintesa da un necessario monito: “Non chiederci la parola che squadri da ogni lato / l’animo nostro informe, e a lettere di fuoco / lo dichiari”.
La poesia dei “Versi livornesi” che straripa, i suoi sortilegi che non si accontentano nè prima nè dopo, nel nome della madre, di un unico canzoniere appositamente delegato, per quanto acuto e sbaragliante, più “naturale” e persuasivo nello scoprire e nel dire della psicologia moderna di Sigmund Freud. “Con lei mi metterò a guardare / le candide luci sul mare. / Staremo alla ringhiera / di ferro – saremo soli / e fidanzati, come / mai in tanti anni siam stati. / E quando le si farà a puntini, / al brivido della ringhiera, / la pelle lungo le braccia, / allora con la sua diaccia / spalla se n’andrà lontana: / la voce le si farà di cera / nel buio che la assottiglia, / dicendo “Giorgio, oh mio Giorgio / caro: tu hai una famiglia (“L’ascensore”). E come non ripensare, anche dalle terrazze del paradiso, ai frastornanti vapori di un bar d’inverno di “Ad portam Inferi”? Splendido Caproni.
Un capolavoro. Ma in Rilke il capolavoro non è una dimensione inattingibile o una rara eccellenza. La sua opera abbonda di capolavori, fa del capolavoro una regola.
Perdindirindina
Di Ariosto è veramente ammirevole la scioltezza del versificare, la musicalità e l’ironia giocate sempre sul filo dell’equilibrio, senza stridori. Ma quello che qui più mi piace è lo sguardo dell’autore che si posa sul corpo d’Olimpia, così come accadrebbe se percorresse le rotondità del paesaggio. Dopo di lui ci hanno provato in molti, anche contemporanei. Forse anche in questo Ariosto può essere considerato un classico all’interno di un topos letterario. Non ricordo se vi sia nel Cantico dei cantici – dovrei rileggerlo – qualcosa di simile. E bisognerebbe rileggere anche certi autori latini.
Fin dal primo verso di questa poesia di Penna la dimensione si fa definitamente onirica, non solo per la surreale nota cromatica ma per l’assenza di ogni specifica toponomastica; cosicché tutto si fa sospeso. L’ora che da sempre volge al desio introduce il lettore al notturno e al sentimento – l’amore – che più gli si confà. E tuttavia non il buio ma l’oro rimane incancellabile nella mente del lettore.
Un implacabile sguardo sulla realtà quello di Pavese, che rilegge in chiave novecentesca l’eterno binomio amore-morte e che non riesce mai a separare il senso di quest’ultima dal quotidiano esistere, anche quando la stessa esistenza dovrebbe essere sublimata dalla forza del sentimento. La donna, la speranza, anche la poesia sono inutili appigli per chi può solo precipitare nel silenzioso gorgo del nulla.
Matteo Mazzone
Dopo il lungo romanzo ideologico dei “Canti”, che analizza il personaggio come poeta e come uomo di vita, “La Ginestra”, in ring composition, ricalca uno dei primissimi temi leopardiani, ovvero quello di un io corale, fatto di più voci, ma tutte riassunte nella modalità espressiva del nostro poeta, che già prepotentemente si era avvertito nelle splendide canzoni patriottiche “All’Italia” e “Sopra il monumento di Dante”: se in queste due liriche la federazione umana è vista come inadempiente al suo dovere ed al suo diritto di costituire una e sempre unita nazione, ne “La ginestra” Leopardi torna ad aizzare, ora più pacatamente – poiché smorzata la virtus giovanile, il grido ribelle – gli animi degli uomini, contro quella macchina cosmica che trascende ed ignora l’umanità: ormai meditata e salda è la convinzione relativa all’infelicità come prodotto della Natura – meditazione che ha trovato luogo nelle “Operette Morali”. “L’empia natura” è la sola colpevole dei mali e del tedio che l’individuo sopporta dolorosamente.
L’opera come colpa: non è forse questa una delle domande principali che l’artista si domanda, poeta o pittore che sia, finita la creazione? Il processo demiurgico sottende percezioni ed emozioni (Balzac nel suo “Capolavoro sconosciuto” bene lo evidenzia), tanto da invitare il creatore ed il modellatore della materia ad inserire egli stesso ed essa stessa in una dimensione irreale ed allo stesso tempo reale. Proprio il bilanciamento tra queste due parallele apparentemente mai intersecabili – ovvero realtà ed irrealtà – crea un’opera artisticamente valida, un’immagine scrittoria o visiva completa nel suo complesso assemblaggio. Se troppo irreale, rimane una “immagine” che si fa “colpa”, “vaniloquio” fine a se stesso, prosopopea artistica, una “derelitta plaga” che non può altro che “ricadere su se medesima”. Se troppo reale, lo slancio verticistico verso un Assoluto ideale, trascendente di cui ogni opera si fa portavoce si annulla irrimediabilmente: decade quel senso di evasione, di incomunicabile corrispondenza e sentimento tra individuo ed opera. Così il suo segreto che sfuma, la sua “anima” in fuga saranno intrappolate, per sempre, in un non-detto, in un incompreso colloquio tra artista ed opera, la quale si presenterà come solo specchio della sua bellezza, ora e sempre narcisistica vuotezza.
Ancora un’inclassificabile, tenue voce del Novecento (un figlio di Saba, a cui non a caso dedicherà una splendida lirica ne “Gli Strumenti umani”), una coscienza della storia: parola che si fa maestra di devozione e di divulgazione. Ora è l’esperienza del poeta, del suo essere stato partecipe e prigioniero di una guerra votata al male per il male, ad essere l’unica ricognizione possibile, l’unico testamento poetico lasciato a ricordo di un presente per un futuro. La morte del soldato sulla spiaggia è immagine fredda, toccante, innocente quanto dolorosamente reale: a Sereni resta una morte tutta spirituale, etica e morale. Una pressante e pesante condizione di esclusione, che apparta Sereni uomo dalla Storia, nella quale, come una marionetta in balìa del caso e a balia di esso, egli si sente vorticosamente ed impotentemente trascinato. Il cruccio dell’inattività, il suo dolore per la passività.
Pietro Paolo Tarasco
Più di vent’anni fa, non mi fu difficile inabissarmi nella poetica di Federigo Tozzi quando mi cimentai per illustrare uno dei suoi rari racconti “Le cicale” e che l’autore dedicava a Glauco, suo figlio. Fin da subito restai affascinato dalla sua sublime poetica e da quel mondo così reale e naturale che ancora oggi è ben impresso in me. La lettura di quel testo mi condusse immediatamente nei ricordi della mia infanzia quando ascoltavo anch’io le garrule cicale. “Tu pensi alle cicale, balocchi vivi dell’estate” scrive Tozzi e, ancora, “Fra te e loro ci sarà sempre una distanza che ti pare grande come il cielo che va da olivo ad olivo” e “Cantano: ma ascolti di più, involontariamente, i battiti del tuo cuore” ed infine “Ed, ascoltando le cicale, vorrei non morire mai”.
Chiara Scidone
“Ossi di seppia”, una delle mie raccolte preferite in assoluto. Trovo affascinante il sentimento di emarginazione che prova Montale, il modo in cui esprime il suo disagio e dolore esistenziale. Nonostante il “male di vivere”, ne “i limoni”, io ci vedo comunque un bagliore di speranza, come se Montale potesse comunicare con la natura e capire cosa essa vuole trasmettergli, anche se alla fine, data la tendenza pessimistica del poeta, la speranza svanisce nel nulla. Un’altra poesia che trovo bellissima è “meriggiare pallido e assorto”.
Lorenzo Dini
Poesia magnifica dove la naturalezza dell’elegia della vita quotidiana, il fantastico ricordo della madre e la famosa “cantabilità”di Caproni, tre fra gli elementi più accattivanti del poeta, raggiungono risultati sorprendenti. Significativa la citazione della canzone popolare “paloma blanca”: essa costituisce un esempio di mise en abyme. La colomba bianca della canzone, inviata all’amata, in questa poesia è mandata dalla madre a consolare il poeta (posandosi sulla sua “stanca / spalla”), come anticipando, ribaltandolo, il motivo di “Preghiera” del “Seme del Piangere”. Inoltre sembra che quando Caproni subisca la perdita di una persona particolarmente cara, egli senta il bisogno di supportare il testo facendo ricorso o a canzoni popolari, o a testi classici radicati nella tradizione; è il caso di “Ultima preghiera” che rimanda alla ballata cavalcantiana, o per la morte del fratello Piero: la poesia “Atque in perpetuum frater” fa chiaro riferimento al carme 101 di Catullo.
Così come ricorda Marchi, “Ossi di seppia” è uno dei libri più potentemente antidannunziani del nostro primonovecento, perché Montale si avvale di una continuità linguistica rispetto alla tradizione per l’attraversamento critico del Vate rinnovando ideologicamente la poesia. E di questa lezione appresa, Montale, parco di riconoscimenti, ravvisa il primato non in se stesso ma nell’opera di Gozzano, nel celebre saggio a lui dedicato. Montale ci dice così che è dovuto passare attraverso «bossi ligustri e acanti» per raggiungere un territorio suo, icasticamente rappresentato, nella poesia d’apertura degli “Ossi”, dai suoi antieloquenti e tuttavia solari limoni.
Elisabetta Biondi della Sdriscia
“Nugae”, poesie leggere, sciocchezze, cose di poco conto, chiamò Catullo le sue poesie, perché abbandonavano i temi tradizionali della cultura romana per concentrarsi sull’individuo, sui suoi sentimenti e stati d’animo. In questo carme si parla della morte di un passero caro a Lesbia, con una modernità sorprendente: proviamo a pensare all’affetto che ci lega ai nostri animali domestici e questa poesia uscirà dal ricordo un po’ noioso dei banchi di scuola per apparirci in tutta la sua grazia e la sua freschezza! Oltre al passero che pigola e saltella dipinto con l’immediatezza di un’istantanea, in questa poesia possiamo cogliere il dolore di Lesbia visto attraverso lo sguardo intenerito e commosso di Catullo. Non manca, infine, neppure una riflessione più profonda, gnomica, sulla morte e la sua irreparabilità. La morte è vista come tenebra che strappa all’uomo tutto ciò che ama, la morte è impossibilità di rivedere chi ci è caro: nel testo, infatti, Catullo utilizza due volte termini che fanno riferimento al buio (iter tenebricosum e malae tenebrae) riferendosi alla morte e due volte la parola occhi (oculis e ocelli).
Sabina C.
Chimera: donna o poesia? E’ la spassionata ricerca di entrambe che muove il poeta e che trova compiuta espressione nell’inebriante e misteriosa atmosfera abitata da chimere evanescenti, impalpabili, inafferrabili, abbaglianti, invocate ed evocate nel dispiegarsi di sensazioni visive e sonore che catturano in un crescendo di dolcezza e musicalità .
Il glicine rapisce, cattura, invade, pervade, si avviluppa, flessibile, irrefrenabile, si espande, con rinnovata e sinuosa grazia. E stordisce la sua inebriante fragranza,che smaschera, mette a nudo prepotentemente mistificazioni e autoinganni, stronca!
Laura Diafani
Mai fiore appare così violento e puro insieme, fragile (“caduco”) e irresistibile insieme: un’aggressione tumultuosa inevitabile e inondante, che ridicolizza come pavida e inefficace l’autodifesa – “a puntellare lo scostrato intonaco / del mio nuovo edificio”.
Rileggevo ora l’Introduzione di Davide Lajolo alla sua biografia di Pavese, appunto ‘Il “vizio assurdo”‘, Storia di Cesare Pavese’ (ll Saggiatore 1960), che trovai tempo fa su una bancarella. Lajolo riferisce parole private di una conversazione con Pavese che vanno in direzione di quella ossimorica e latente unità nella diacronia che Marco Marchi evidenziava: “Non sono per questo un uomo complesso, come ha scritto chi ha parlato dei miei libri. è complessa la vigna, dove l’impasto concimi-sementi, acqua e sole, dà l’uva migliore, ma non quella dove, troppo spesso, alla stagione del raccolto le viti sono inaridite e senza grappoli. Io sono fatto di tante parti che non si fondono; in letteratura l’aggettivo adatto è eclettico. è proprio l’aggettivo che odio di più nella vita e nei libri, ma il mio odio non basta a espellerlo” (p. 10).
Duccio Mugnai
Tre quartine a rima alternata e un distico finale a rima baciata per far emergere dal contesto lirico l’assonanza “gone” / “love alone”; questo lo schema funzionale, ma al contempo affascinante per descrivere le tante angosce e tribolazioni dell’esistenza, utile e possibile calco per un'”hamletica” resa teatrale della maturità “shakespeariana”, così dolorosamente e tragicamente incentrata sulla fuggevolezza umanissima ed incomprensibile del dubbio. Il finale sembra un tipico “accordo” del bardo di Avon, cioè un gioco raffinato tra parole, tra ironia e ricerca della verità, con la consapevolezza ed il risultato innegabile di un’indecifrabilità dell’amore. Verso se stesso? Verso un altro / un’altra? Forse realmente verso la passione irresistibile dell’esistenza, nonostante tutto? Eppur solo lui e pochi altri riescono a scrivere e pronunciare “love”, per bocca di attori o veri amanti, in modo non ridicolo, sottolineandone sobriamente tutta la drammaticità. Sì, Shakespeare e Dante (“Amor, ch’a nullo amato amar perdona, / mi prese del costui piacer sì forte, / che, come vedi, ancor non m’abbandona”).
L’intervento poetico della Sexton è molto più che provocazione, è un attacco esistenziale contro il perbenismo. Dichiarandosi “strega”, la donna rivendica non solo un femminismo coraggioso e libero, ma una vibrante, necessaria protesta contro i miti borghesi del capitalismo consumistico americano. E la forza arcana, volutamente e coscienziosamente favolosa e misterica delle parole, irresistibile “malefizio” femminile, affascina e trascina, perché la Sexton non risparmia la verità a se stessa ed alla società ipocrita. La consapevolezza di essere donna con tutte le sue contraddizioni, verità e slanci di vita, la difende da infingimenti fino all’estrema dichiarazione, così disperante, quanto inevitabile: “[…] A woman like that is not ashamed to die. / I have been her kind”.
Come nella poesia di Sinisgalli o in Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi, peraltro autore del ritratto di Rocco Scotellaro, che appare in questo intervento sulla sua opera, finemente delineata da Marchi, è indiscutibile il rivelarsi, l'”apocalisse” laica di un mondo rurale, antichissimo, non ancora completamente perduto, dove la miseria più nera diventa sinonimo di vita travagliatissima, ma autentica nel rispetto dell’anima più segreta e più vera dell’Italia, cioè la profondità delle campagne, il mitico connubio tra terra e essere umano. I gesti della madre sono rari nella loro preziosità: “ti vedo sempre tesa / a rubarmi un po’ di affetto, / tu che a moine non mi hai avvezzato”. “Uno scialle sacro” sottolinea la perentorietà d’amore di un figlio; seppur disperato nella registrazione lirica della sua solitudine, ancora rivolge alla madre le ultime, consuete parole di tutti i figli, mormorate o graffiate nell’anima: ” non morire, mamma mia, che ti vorrò più bene”.
Perdindirindina
Sarò banale, ma non mi viene leggendo sopra altra parola se non bellezza. Siamo agli albori della poesia, eppure c’è già una matura eleganza nei secoli a venire difficilmente eguagliabile. Omero, ovvero il canto di una intera civiltà, di un popolo. Il solo pensiero dà i brividi. Che dire poi della Bemporad e del suo esercizio della traduzione. Ascoltare la sua lezione sui versi qui citati è sicuramente illuminante; potrebbe esserlo anche per i nostri giovani, per capire quanta attenzione, pazienza, maturità si celi nel lavoro di trasposizione da una lingua ad un’altra. Lavoro dunque tuttaltro che meccanico ma che esige dedizione e passione. Ne trovo mirabili esempi in sintagmi come l’allitterante “lento logorio”, che sembra voler allungare o meglio trascinare oltre il dolore, o nell’espressione ossimorica “gustiamo l’acre voluttà del pianto”. Qui la solennità del passo si sposa con accenti intensissimi di pathos, che la Bemporad mi pare rendere benissimo.
Infine, tornando a Omero e al suo protagonista, non passa certo inosservato il commovente abbraccio tre volte tentato e tre volte disatteso, talmente commovente, talmente intriso di epico e di umano al tempo stesso, da perdurare attraverso secoli e civiltà fino al nostro Dante.
Questa poesia mi fa pensare al mito platonico dell’androgino, di per sé bellissimo e nel quale ho sempre un po’ creduto. Si può amare in tanti modi: ci può essere amore a prima vista e non; si può anche imparare ad amare col tempo. Ma certo ci sono incontri che capitano poche volte nella vita e li distingui perché incontrarsi per la prima volta diviene sinonimo di riconoscersi: come se una medesima educazione sentimentale, una stessa visione del mondo ci legasse, a dispetto del tempo e dello spazio che può unire o separare. È un Amore che può concretizzarsi o rimanere platonico, ma certo ha in sé qualcosa di superiore e di sconvolgente. Disse Catherine: “Io sono Heathcliff”.
Un bellissimo gioco d’inganni, questo del “Soliloquio” di Ungaretti, fra il poeta e il suo oggetto d’amore, a riprova del fatto che la vita è sogno. Eppure, nel finale, la purezza sembra per una volta fare Amore vincitore.
Nell’illustrazione: Pietro Paolo Tarasco, Il Pellegrino, acquerello, 2000
Seguici anche sulla Pagina Facebook del Premio Letterario Castelfiorentino
e sulla pagina personale https://www.facebook.com/profile.php?id=100012327221127
ARCHIVIO POST PRECEDENTI
Le ultime NOTIZIE DI POESIA
NOTIZIE DI POESIA 2012 , NOTIZIE DI POESIA 2013 , NOTIZIE DI POESIA 2014 , NOTIZIE DI POESIA 2015 , NOTIZIE DI POESIA 2016